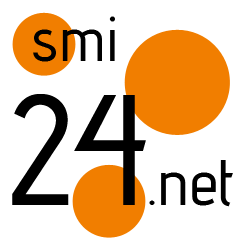L’arrosto di Natale e quel rito in famiglia
Pavia. Il Natale, a tavola, un tempo cominciava molto prima del tradizionale pranzo in famiglia. Cominciava dal brodo. Quello serio, che sobbolliva piano per ore, profumando la casa già dal mattino. E spesso il protagonista era lui: il cappone. Un animale che, nella cucina di una volta, aveva almeno tre vite e nessuna veniva sprecata. La prima era nella pentola. Il cappone intero finiva immerso nell’acqua fredda, insieme a sedano, carota e cipolla, e da lì tirava fuori un brodo ricco, dorato, capace di tenere insieme tortellini, cappelletti o ravioli delle feste. Quando il brodo era pronto, però, il cappone non aveva ancora finito il suo lavoro. Si faceva attenzione a toglierlo dal brodo prima che si disfasse. Veniva estratto con cura, ancora integro, lasciato intiepidire per assestarsi. Poi iniziava la seconda vita: ripassato nel forno, rosolato lentamente, spennellato col suo stesso grasso fino a diventare arrosto.
[[ge:gnn:laprovinciapavese:15442379]]
Non era la carne succosa e burrosa che conosciamo oggi, ma aveva il sapore della festa, quello vero, costruito con pazienza e attesa. E se in casa c’era disciplina, e soprattutto se nessuno lo finiva tutto subito, arrivava anche la terza vita: la carne avanzata, spolpata dalle ossa fino all’ultimo pezzettino, tritata finemente, diventava ripieno per i ravioli del giorno dopo. Il cappone, così, riusciva a nutrire più pasti, più giorni e più persone. Negli arrosti dei volatili, poi, il ripieno era una forma di intelligenza domestica. Valeva la stessa regola delle polpette: recuperare, insaporire, allungare senza perdere dignità. Un po’ di carne dell’animale stesso (magari le sue interiora), pane ammollato, uova, formaggio, erbe e spezie. Che fosse cappone, pollo o faraona, l’aggiunta del ripieno permetteva di servire porzioni più piccole di arrosto, sfamando ugualmente grazie all’aggiunta del pezzo di ripieno. Con questo semplice escamotage, con un solo animale si riusciva a sfamare una tavolata più grande e a Natale, si sa, i posti a sedere aumentavano sempre.
Era una cucina pensata per la convivialità, non certo per l’abbondanza ostentata. Ogni fetta aveva il suo peso, ogni ripieno il suo perché. Si mangiava tutti, meglio, e nessuno restava escluso.
E poi c’era l’oca. Da buon lomellino, il ricordo dell’oca arrosto a Natale è inevitabile. Un’immagine che ha qualcosa di dickensiano: il pollaio, il freddo, l’attesa, la consapevolezza che quell’animale era “per la festa grande”. L’oca era perfetta quando a tavola si era in tanti: carne generosa, grasso prezioso, sapore deciso. Nulla andava perso nemmeno lì. Le regalie: cuore, fegato, ventriglio diventavano paté o finivano direttamente nel ripieno. Il grasso veniva raccolto con cura, poteva insaporire il risotto o le patate arrosto, e poi c’era il momento più atteso: i ciccioli. Un premio, una festa nella festa, il segno che anche l’ultima parte aveva trovato il suo posto.
Ripensandoci oggi, quegli arrosti non erano solo piatti delle feste. Erano esercizi di equilibrio, di rispetto e di ingegno. Raccontavano un tempo in cui cucinare significava davvero prendersi cura, moltiplicare le possibilità di un ingrediente, e usare il tempo come ingrediente principale. Forse è anche per questo che l’arrosto di Natale ha ancora quel sapore speciale: non è solo carne, ma memoria. Di brodi che sobbollivano piano, di ripieni fatti con le mani, di tavole lunghe e di animali che, almeno una volta all’anno, riuscivano a nutrire non solo il corpo, ma anche la famiglia. — © RIPRODUZIONE RISERVATA