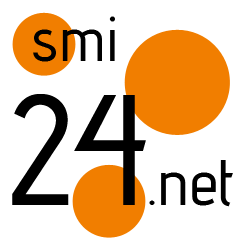Tecnologie emergenti, innovazione e sfide per le imprese italiane nel contesto globale: l’opinione di Stefano Quintarelli
In un momento storico in cui l’innovazione corre più veloce della capacità dei sistemi economici e istituzionali di comprenderla, il dibattito sul futuro tecnologico dell’Italia assume un valore strategico.
Il nostro Paese è ricco di competenze, ricerca, talento imprenditoriale, ma allo stesso tempo è frenato da barriere culturali, strutturali e finanziarie che ne limitano il potenziale.
Su questo abbiamo sentito Stefano Quintarelli, figura centrale nell’evoluzione digitale italiana, fondatore del primo ISP italiano (I.NET), ideatore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), già deputato e membro del Gruppo di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale presso la Commissione Europea.
Quali tecnologie avranno l’impatto più significativo nei prossimi cinque anni?
Le tecnologie emergenti stanno già trasformando economia, produttività e società. L’intelligenza artificiale va però distinta: esiste un’AI “noiosa”, quella che ottimizza processi e automatizza attività, e un’AI “sexy”, quella generativa, spesso sopravvalutata rispetto alle sue reali capacità.
L’aspetto davvero rivoluzionario è l’interoperabilità, cioè la possibilità per i sistemi di scambiarsi dati senza intervento umano. Questo riduce inefficienze e costi, come già avviene con strumenti come SPID o i pagamenti digitali, e diventerà sempre più centrale.
L’AI generativa, invece, non replica l’intelligenza umana e non può svolgere compiti come riconoscere bugie o prevedere crimini, nonostante le aspettative eccessive create attorno a essa.
La prima barriera è culturale. Le persone non amano il cambiamento e tendono a difendere lo status quo. A questo si aggiungono strutture organizzative e processi rigidi, difficili da modificare.
Le aziende italiane, inoltre, sono mediamente più piccole e meno managerializzate rispetto a quelle di altri Paesi. Questo limita l’ingresso di competenze fresche, spesso più preparate sulle tecnologie emergenti. Tuttavia, quando avviene un cambio generazionale, la situazione può ribaltarsi rapidamente: l’imprenditore giovane, più vicino alla tecnologia, può imprimere una forte accelerazione.
In sintesi: cultura, organizzazione, governance e dimensione aziendale sono i principali ostacoli.
In un mercato dominato da grandi player globali, come possono competere le PMI italiane?
La risposta è semplice: cercando spazi che non sono ancora dominati dai grandi player. E la tecnologia permette di riscrivere tutto, in ogni settore.
Faccio un esempio recente: ho parlato con un gruppo di giovani che ha sviluppato un additivo per la perovskite dei pannelli fotovoltaici, capace di aumentarne la stabilità di quasi un ordine di grandezza. Un’innovazione che può cambiare un intero mercato.
Nel mio lavoro di venture capitalist vedo ogni giorno idee straordinarie. Oggi la conoscenza è accessibile ovunque, i talenti sono ovunque, il capitale è disponibile. Non ci sono mai state così tante opportunità per chi ha un’idea e la determinazione per realizzarla.
Le PMI devono aprirsi ai giovani, ai nuovi talenti, a chi porta visione e competenze tecnologiche. È un passaggio necessario.
Quali competenze mancano oggi al tessuto imprenditoriale italiano?
In parte l’ho già detto: mancano competenze manageriali, apertura al cambiamento, familiarità con le tecnologie emergenti. Ma soprattutto manca la capacità di integrare nuove competenze dall’esterno, lasciando spazio a chi può portare innovazione.
Qual è la misura di politica industriale più urgente per sostenere l’innovazione in Europa?
Serve una riforma profonda del mercato dei capitali, simile a quella che negli Stati Uniti ha trasformato il settore negli anni ’70. All’epoca una modifica normativa permise ai fondi pensione di investire in venture capital, liberando enormi quantità di capitale privato.
Oggi il confronto è impietoso: il capitale di rischio pre-borsa in Europa è di 73 miliardi, negli Stati Uniti di 13.000. Un rapporto di 1 a 20.
Non è una questione di rischio reale: i dati della Banca Centrale Europea mostrano che, come asset class, il venture capital non è più rischioso di altri investimenti. È una questione culturale. Abbiamo paura dell’innovazione.
Se non superiamo questa barriera, continueremo a vedere le nostre migliori aziende acquisite dai grandi fondi americani, che dispongono di risorse enormemente superiori.
L’Europa produce innovazione, ma non riesce a farla crescere. La priorità è creare un mercato unico dei capitali, più liquido e più aperto all’investimento in innovazione. Solo così potremo trattenere e far maturare le nostre eccellenze.
Come valuta oggi il rapporto tra istituzioni e mondo tecnologico?
Le istituzioni sono governate dalla politica, e la politica risponde alla domanda dei cittadini. Il punto è che i cittadini non chiedono innovazione tecnologica: chiedono protezione, tutela. Siamo un Paese – e un continente – anziano, e questo si riflette nella paura del cambiamento e nella difficoltà a decodificare la modernità. Di conseguenza, la politica si concentra su ciò che l’elettorato domanda, non su ciò di cui avrebbe bisogno.
Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione istituzionale verso l’innovazione. In molti Paesi esistono commissioni parlamentari dedicate alla tecnologia, che obbligano la politica a occuparsene anche quando non è una richiesta esplicita dei cittadini. Einaudi diceva che “il mercato esprime domande, non bisogni”: ecco, noi abbiamo un bisogno enorme di innovazione, di produttività, di digitalizzazione, di interoperabilità. Ma la domanda politica va in un’altra direzione.
Oggi il tema è residuale, spesso affrontato da pochi parlamentari o figure istituzionali che hanno una conoscenza superficiale della materia e parlano di tecnologia più per “darsi una mano di bianco” che per reale competenza. Quando ero in Parlamento, nella XVII legislatura, su circa mille tra deputati e senatori, gli informatici eravamo cinque. Questo dà la misura del problema.
Serve un cambiamento strutturale, guidato da una leadership che comprenda davvero la centralità dell’innovazione. Finora, questa figura non l’abbiamo avuta.
Quali rischi comporta una regolazione troppo rigida o troppo permissiva?
I rischi sono evidenti in entrambi i casi. Una regolazione troppo permissiva favorisce la creazione di posizioni dominanti e lo sfruttamento di categorie più deboli. Una regolazione troppo rigida può soffocare l’innovazione.
Trovare l’equilibrio è un compito politico complesso. Spesso si dice che l’Europa regola troppo, ma bisogna vedere da dove arriva questa critica: spesso proviene da soggetti molto potenti che avrebbero tutto da guadagnare da una riduzione delle regole. L’assenza di regolamentazione su concorrenza, pluralismo e disciplina dei mercati avvantaggia sempre i più grandi.
E non dimentichiamo il contesto: l’Europa investe 70 miliardi nell’innovazione, gli Stati Uniti 1.300. Una deregolamentazione totale non giocherebbe a nostro favore.
Quali scenari immagina per l’Italia dell’innovazione nei prossimi dieci anni?
Ho parlato spesso di tecnologie digitali perché sono il mio ambito, ma l’innovazione non è solo digitale. C’è un’enorme quantità di ricerca e sviluppo nei materiali, nella chimica, nel biotech. E in questi settori siamo fortissimi: non abbiamo nulla da invidiare a nessuno.
Un Paese lungimirante dovrebbe incentivare e scommettere su alcuni di questi settori strategici. Ma è una domanda complessa: non esiste una risposta giusta, esistono scenari possibili, e bisogna avere il coraggio di sceglierne uno.
Il rischio, però, è che continuiamo a essere subalterni dal punto di vista tecnologico. Se non investiamo con decisione, non vedo grandi cambiamenti nell’adozione tecnologica delle imprese italiane rispetto a oggi.
Se potesse dare un solo consiglio ai giovani che vogliono lavorare nella tecnologia, quale sarebbe?
Direi di cercare la propria passione nel mondo tecnologico e dedicarcisi completamente. Se fai ciò che ami, non lavori un solo giorno della tua vita.
Viviamo nell’era delle opportunità: conoscenza, competenze, persone, risorse, capitali… tutto è più accessibile che mai per chi ha un sogno e la determinazione di inseguirlo. Il mio consiglio è semplice: trovate il vostro sogno, impegnatevi a fondo e le possibilità saranno infinite.
Qual è oggi la sua sfida personale o professionale?
Ho attraversato molte stagioni: accademica, imprenditoriale, manageriale, legislativa, amministrativa, internazionale. Oggi la mia sfida è quella di Venture Capitalist.
Credo profondamente in ciò che ho detto finora, e per questo penso che questa fase della mia vita professionale debba essere dedicata ad aiutare giovani imprenditori italiani a crescere e ad avere successo, non solo in Italia. Lo sto facendo con il fondo Rialto, insieme a soci straordinari.
Quali sono, secondo lei, i principali limiti del sistema fiscale italiano nel supportare l’innovazione tecnologica?
Non sono un tuttologo, e non conosco abbastanza a fondo il sistema fiscale italiano per dare una risposta tecnica. Posso però osservare cosa accade altrove.
Negli Stati Uniti, oltre alla famosa riforma ERISA che ha dato vita al venture capital moderno, esistono misure come lo Small Business Act e lo Small Business Securities Act. Tutte le amministrazioni pubbliche devono destinare una quota degli acquisti alle piccole imprese. Inoltre, i capital gain su quote detenute per almeno cinque anni in piccole aziende sono detassati.
Non si tratta solo di mettere risorse nel sistema, ma di incentivare gli investimenti e ridurre il rischio per chi sostiene le imprese innovative, anche orientando parte della domanda pubblica.
In Italia esistono incentivi per investire in startup, ma spesso vincolati a fondi che investono solo in aziende italiane. Questo può funzionare se c’è già abbastanza liquidità per far crescere un’industria del venture capital. Altrimenti rischia di diventare solo un sussidio. Bisogna decidere se l’obiettivo è sussidiare o sviluppare un settore: nel secondo caso, i vincoli andrebbero rimossi.
Se potesse introdurre una sola misura per accelerare la crescita delle startup innovative, quale sarebbe?
In realtà non può essercene una sola, quindi ne indico due.
La prima: creare domanda per le startup innovative, attraverso incentivi e destinazione mirata della spesa pubblica. Se crei un mercato, riduci il rischio per chi investe e rendi più facile finanziare le startup.
La seconda: facilitare il rapporto tra aziende italiane e imprenditori italiani all’estero. L’innovazione è globale, non possiamo restare un’isola. Abbiamo una diaspora di talenti straordinari, connessi ai principali ecosistemi internazionali.
Un dato significativo: due anni fa, gli investimenti in startup italiane erano 1,2 miliardi. Gli investimenti in startup estere fondate da italiani erano 700 milioni. Significa che circa il 40% del capitale che punta su talenti italiani va a sostenere chi fa impresa fuori dal Paese.
Dobbiamo costruire ponti, non barriere. Favorire gli italiani che operano all’estero è fondamentale per far crescere il nostro ecosistema.
Qual è il principale ostacolo culturale alla trasformazione digitale in Italia?
Il primo ostacolo è l’età. Siamo un Paese anziano, e questo incide sulla propensione al cambiamento.
Poi c’è la sindrome dell’invented here: diffidiamo delle innovazioni nate in Italia. Conosco molte aziende che hanno avuto successo nel nostro Paese solo dopo essersi date una “patina” straniera. È un complesso di inferiorità che non ha alcuna ragione di esistere: tecnici e imprenditori italiani guidano divisioni strategiche nelle maggiori aziende globali.
Eppure fatichiamo a liberarci di questa subalternità culturale. È un freno potente, insieme all’ostacolo anagrafico.
Come si può aumentare la fiducia dei cittadini nelle tecnologie emergenti?
In realtà, la fiducia è già molto alta, forse persino troppo, a giudicare dall’uso massiccio che le persone fanno della tecnologia.
Il problema non è la fiducia, ma la consapevolezza. Oggi la società è frammentata in gruppi, ognuno esposto a flussi informativi diversi. Non esiste più un “metronomo unico” della comunicazione. Questo rende difficile costruire una consapevolezza diffusa e omogenea sui rischi e sulle opportunità delle tecnologie emergenti.
Che ruolo dovrebbero avere scuole e università nella formazione digitale?
Un ruolo importante, che in parte già svolgono. Le scuole e le università italiane sono di buon livello anche sul fronte tecnologico, soprattutto se confrontate con altri Paesi.
Dovremmo però ampliare l’insegnamento della programmazione, dell’informatica, della cultura tecnologica. Come ricordava Piero Angela, in Italia consideriamo “cultura” solo quella umanistica, ma esiste anche una cultura scientifica e tecnologica che va valorizzata.
E poi c’è un altro tema: la contaminazione tra università e aziende. Negli Stati Uniti, una persona di 40 anni ha già fatto due cicli completi tra accademia e lavoro. Da noi questo non accade. Dovremmo favorire molto di più il passaggio di competenze tra mondo accademico e mondo produttivo, rendendo più chiaro alle persone cosa fanno le aziende, qual è il loro ruolo sociale. Olivetti questo lo aveva capito benissimo.
L'articolo Tecnologie emergenti, innovazione e sfide per le imprese italiane nel contesto globale: l’opinione di Stefano Quintarelli proviene da Giornalettismo.